|
|
-
-
-
-
|
|
| Barocco
emiliano |
|
Ottobre
2008 |
 Fig.
1
- Carta n. 35 del "Taccuino Senese"
- Giuliano
da Sangallo. "Lo fece edificare, e se ne valse per
uso di propria abitazione il chiarissimo letterato e storico fiorentino
messer Bartolommeo Scala. Da' suoi discendenti passò nelle monache
di San Clemente; da esse in monsignor Alessandro dei Medici arcivescovo
fiorentino, e poi papa Leone XI; e finalmente nella nobilissima casa
Della Gherardesca, la storica celebrità della quale non può ignorarsi
da' dotti. Tutti questi proprietari hanno progressivamente migliorato
il palazzo ed ampliato il giardino annesso in modo, che l'uno e l'altro,
presi insieme, occupano una superficie di braccia 122.744" - F.
Fantozzi, Nuova guida ovvero descrizione storico-artistica-critica
della città e contorni di Firenze. " Tra i migliori seguaci
del Brunelleschi, restò fedel al linguaggio del primo rinascimento
anche nel periodo di Bramante e Raffaello. - Il superamento
del brunelleschianesimo non in nome di uno scontro frontale fra maniera
fiorentina e maniera romana, bensi' snervando il linguaggio di Filippo
in favore di complessi spaziali nuovi.." G. Morolli, Fi e
il classicismo un rapporto difficile. Fig.
1
- Carta n. 35 del "Taccuino Senese"
- Giuliano
da Sangallo. "Lo fece edificare, e se ne valse per
uso di propria abitazione il chiarissimo letterato e storico fiorentino
messer Bartolommeo Scala. Da' suoi discendenti passò nelle monache
di San Clemente; da esse in monsignor Alessandro dei Medici arcivescovo
fiorentino, e poi papa Leone XI; e finalmente nella nobilissima casa
Della Gherardesca, la storica celebrità della quale non può ignorarsi
da' dotti. Tutti questi proprietari hanno progressivamente migliorato
il palazzo ed ampliato il giardino annesso in modo, che l'uno e l'altro,
presi insieme, occupano una superficie di braccia 122.744" - F.
Fantozzi, Nuova guida ovvero descrizione storico-artistica-critica
della città e contorni di Firenze. " Tra i migliori seguaci
del Brunelleschi, restò fedel al linguaggio del primo rinascimento
anche nel periodo di Bramante e Raffaello. - Il superamento
del brunelleschianesimo non in nome di uno scontro frontale fra maniera
fiorentina e maniera romana, bensi' snervando il linguaggio di Filippo
in favore di complessi spaziali nuovi.." G. Morolli, Fi e
il classicismo un rapporto difficile. |
|
| Taccuino
romano |
|
Ottobre
2008 |
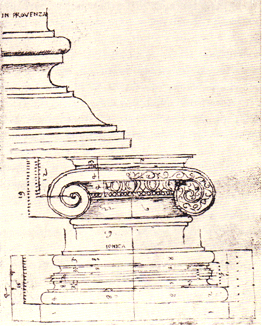 Fig.
1
- Carta n. 35 del "Taccuino Senese"
- Giuliano
da Sangallo. "Lo fece edificare, e se ne valse per
uso di propria abitazione il chiarissimo letterato e storico fiorentino
messer Bartolommeo Scala. Da' suoi discendenti passò nelle monache
di San Clemente; da esse in monsignor Alessandro dei Medici arcivescovo
fiorentino, e poi papa Leone XI; e finalmente nella nobilissima casa
Della Gherardesca, la storica celebrità della quale non può ignorarsi
da' dotti. Tutti questi proprietari hanno progressivamente migliorato
il palazzo ed ampliato il giardino annesso in modo, che l'uno e l'altro,
presi insieme, occupano una superficie di braccia 122.744" - F.
Fantozzi, Nuova guida ovvero descrizione storico-artistica-critica
della città e contorni di Firenze. " Tra i migliori seguaci
del Brunelleschi, restò fedel al linguaggio del primo rinascimento
anche nel periodo di Bramante e Raffaello. - Il superamento
del brunelleschianesimo non in nome di uno scontro frontale fra maniera
fiorentina e maniera romana, bensi' snervando il linguaggio di Filippo
in favore di complessi spaziali nuovi.." G. Morolli, Fi e
il classicismo un rapporto difficile. Fig.
1
- Carta n. 35 del "Taccuino Senese"
- Giuliano
da Sangallo. "Lo fece edificare, e se ne valse per
uso di propria abitazione il chiarissimo letterato e storico fiorentino
messer Bartolommeo Scala. Da' suoi discendenti passò nelle monache
di San Clemente; da esse in monsignor Alessandro dei Medici arcivescovo
fiorentino, e poi papa Leone XI; e finalmente nella nobilissima casa
Della Gherardesca, la storica celebrità della quale non può ignorarsi
da' dotti. Tutti questi proprietari hanno progressivamente migliorato
il palazzo ed ampliato il giardino annesso in modo, che l'uno e l'altro,
presi insieme, occupano una superficie di braccia 122.744" - F.
Fantozzi, Nuova guida ovvero descrizione storico-artistica-critica
della città e contorni di Firenze. " Tra i migliori seguaci
del Brunelleschi, restò fedel al linguaggio del primo rinascimento
anche nel periodo di Bramante e Raffaello. - Il superamento
del brunelleschianesimo non in nome di uno scontro frontale fra maniera
fiorentina e maniera romana, bensi' snervando il linguaggio di Filippo
in favore di complessi spaziali nuovi.." G. Morolli, Fi e
il classicismo un rapporto difficile. |
|
| Villa
extraurbana |
|
Settembre
2008 |
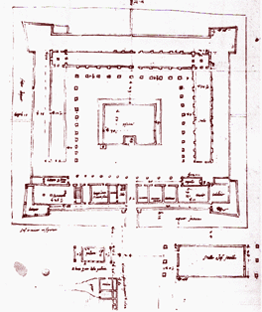 Fig.
1 - Cascine di Tavola
- Pianta
del XVI sec. , attribuita a G. Dosio. Questa tavola riporta
la configurazione del complesso circa un secolo dopo la sua costruzione.
Al centro si trova la pescina; attorno a questa sul retro e
sui lati, vi sono le stalle; di fronte a sinistra le stanze per la
preparazione del formaggio e sulla destra le unità di abitazione.
L' edificio è situato nell'area compresa tra Tavola e Castelnuovo.
Una lettera di Antonio marchetti indica che le fondamenta della Cascina
furono scavate nell'aprile del 1477." Nella seconda metà
del Quattrocento, il giovane Lorenzo de' Medici intraprese al Poggio
a Caiano e nelle zone limitrofe un'intensa campagna di acquisti e
di investimenti terrieri. Lo scopo era quello di creare, accanto alla
villa appena comprata e che avrebbe di lì a poco ricostruito ex novo.
Il progetto laurenziano comprende un vasto complesso unitario. Fig.
1 - Cascine di Tavola
- Pianta
del XVI sec. , attribuita a G. Dosio. Questa tavola riporta
la configurazione del complesso circa un secolo dopo la sua costruzione.
Al centro si trova la pescina; attorno a questa sul retro e
sui lati, vi sono le stalle; di fronte a sinistra le stanze per la
preparazione del formaggio e sulla destra le unità di abitazione.
L' edificio è situato nell'area compresa tra Tavola e Castelnuovo.
Una lettera di Antonio marchetti indica che le fondamenta della Cascina
furono scavate nell'aprile del 1477." Nella seconda metà
del Quattrocento, il giovane Lorenzo de' Medici intraprese al Poggio
a Caiano e nelle zone limitrofe un'intensa campagna di acquisti e
di investimenti terrieri. Lo scopo era quello di creare, accanto alla
villa appena comprata e che avrebbe di lì a poco ricostruito ex novo.
Il progetto laurenziano comprende un vasto complesso unitario. | |
